Paolo Monti - Flottage
Roma, Musis 1997
Per la maggior parte delle persone entrare in rapporto con un’opera
d’arte significa semplicemente porsi dinnanzi ad un quadro o ad una
scultura e cercare di capire cosa ha voluto dire l’autore. Un modo
di vedere le cose apparentemente elementare, ma in realtà basato su
di un buon numero di presupposti che ad un’analisi più accurata
risultano tutt’altro che pacifici. In altre parole dei veri e propri
pregiudizi, quelli a suo avviso più limitativi rispetto alle
modalità con le quali la nostra epoca, sempre più immersa
nell’universo impalpabile delle tecnologie comunicazionali, va
producendo la sua domanda di senso.
Proviamo ad elencarli. Il primo è la convinzione che una creazione
artistica consista esclusivamente in ciò che abbiamo davanti; il
secondo è la certezza che un’immagine d’arte debba essere qualcosa
di ragionevolmente fermo nel tempo e nello spazio; il terzo è la
fiducia nel fatto che un’opera non possa che esporsi integralmente
al nostro sguardo; il quarto ed ultimo, infine, l’idea che la
fruizione estetica resti comunque un processo esterno al suo
soggetto e non autorizzato a modificarlo.
L’originalità della posizione di Monti tuttavia non consiste
nell’aver individuato la necessità di insistere ancora su questo
nucleo di problemi in forza di una loro rinnovata attualità, quanto
nel modo di procedere prescelto. Un modo di procedere che ad onta
della complessità teorica delle questioni poste sul tappeto, si
avvale sempre e soltanto di esperienze le quali, nel coinvolgerci
direttamente con persuasiva immediatezza, non rinunciano a stimolare
in noi il senso del meraviglioso. Non rinunciano cioè ad allargare
fattualmente i nostri orizzonti conoscitivi ora in virtù di un’
inusitata impostazione dell’evento prodotto ora grazie alla messa a
punto di vere e proprie invenzioni tecniche fondate su di un uso
creativo di conoscenze scientifiche più o meno elementari.
Così ad es. all’interno del ciclo di lavoro che Monti ha dedicato al
denaro troviamo delle opere denominate “Perimetrazioni” in cui
grazie ad un semplice espediente (il ritagliare il bordo di
banconote poi rimesse in circolazione) il rapporto tra pubblico e
manufatto artistico viene a snodarsi su due diversi percorsi: quello
della fissità e consapevolezza e quello della mobilità e
inconsapevolezza; ma troviamo anche delle installazioni, denominate
“Immagine di dollaro” in cui addirittura il tempo del guardare
distrugge materialmente un frammento di cartamoneta che potrebbe
essere considerato come un valore certo e tuttavia nel far ciò
instaura un valore di diversa natura.
Così all’interno di un altro ciclo di lavoro, questa volta basato
sulle proprietà del mercurio, un’opera come “Specchio Elastico”
(Elastic Mirror) grazie ad un sistema di sensori e ad un
vibrooscillatore determina l’impossibilità per lo spettatore di
vedere la propria immagine riflessa con nettezza su di una
superficie specchiante che pure, ad evidenza, riflette
tranquillamente l’ambiente che la circonda.
Così, infine, un’opera come “Flottage” fa si che tutti coloro che
vengono a ricadere nello spazio di ripresa di un’apposita telecamera
possono vedere proiettata dinanzi a se la propria sagoma colorata
secondo i diversi livelli di emissione di calore dei rispettivi
corpi nonché posta relazione diretta con movimenti volontari e
funzioni organiche. Il che è come dire che viene a prodursi un nuovo
tipo di ritratto in cui soggetto e riguardante in qualche modo si
scambiano continuamente le parti fondendo tempo della vita e tempo
della fruizione, spazio reale e spazio virtuale in una medesima
creazione, in una pittografia collettiva il cui continuo mutare non
contraddice la stabilità degli intenti e la ragion d’essere
dell’intervento ideato dall’artista.
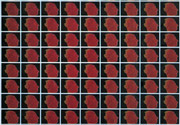
Paolo Balmas
in: "Paolo Monti - Flottage", Roma, Musis 1997
|

