|
“Musis e Monti”
di Luigi Campanella / 1996
La scoperta che la massa è una
forma di energia ha modificato profondamente l’immagine che si ha della
materia, intesa dinamicamente e non più rappresentabile.
Partendo da questo assunto la ricerca artistica che Paolo Monti sta
ormai da tempo conducendo, evidenzia come la materia di cui si compone
l’opera possa solo autorappresentarsi, attraverso accadimenti estetici
prodotti dall’artista.
Un “Orizzonte degli Eventi” dunque, dove la visione innesca processi di
appercezione che assottigliano la demarcazione tra ciò che è evento e la
possibilità di rappresentarlo. Caos programmato che l’artista instaura
lasciando però che sia l’osservatore a compiere il passaggio sensoriale
attraverso una realtà non virtuale ma appercettiva. Non mimesis della
realtà ma indagine attraverso i sensi di immagini fluttuanti che senza
un prima ed un poi si annullano nell’esperienza di un continuo divenire.
Immagini possibili con tendenza a verificarsi, all’interno delle quali
il mutamento è l’unica costante spazio-temporale come nell’opera
Flottage 1995 “Flussi articolati di caldi e di freddi emanati da
soggetti-oggetti termici definiscono immagini cangianti”, che Monti ha
realizzato per MUSIS in occasione della IV Settimana della Scienza e
presentato nuovamente con il contributo di MUSIS e la collaborazione
dell’ENEA, della SONY e dell’AGEMA Infrared Systems, all’interno della
XII Quadriennale di Roma “Ultime Generazioni. Italia 1950-1990”, dove
una telecamera a raggi infrarossi rileva e rivela le radiazioni termiche
prodotte da soggetti ed oggetti i cui flussi articolati di caldi e di
freddi, compresi entro certe temperature, vengono restituiti sotto forma
di immagini simultanee e successive dai colori cangianti a grandezza
naturale, su di uno schermo dimensionato in base allo spazio
disponibile, come in una sorta di “specchio termico”.
Che nel visibile i fotoni compongano a formare immagini in grado di
scatenare il nostro senso estetico rientra nella comune esperienza. Ma
ecco che basta spostare la frequenza della radiazione per scoprire una
nuova dimensione dove le regole dell’estetica ancora non esistono, un
mondo ancora tutto da esplorare dove dominano solo i meccanismi fisici
basilari. L’opera Flottage si sostanzia come punto avanzato ma coerente,
della ricerca artistica di questo autore che prendendo a pretesto
l’impiego di un’avanzata tecnologia, sintetizza l’atteggiamento estetico
e quello scientifico. Le oggettivazioni proprie della scienza conservano
infatti il loro senso essendo essendo comprensibili e misurabili
dall’intelletto, all’interno però di una concettualità che vede spostata
la riflessione sul soggetto e sul suo livello di consapevolezza.
Vedere il proprio corpo come in “un’ombra termica” generata
dall’emanazione dell’energia endogena e riconoscersi in quella forma dai
colori cangianti, in grado di rivelare attraverso la sua misurazione
persino lo stato emotivo di questa esperienza, dissolve l’illusione di
una coincidenza della percezione con la visione.
“Quello sono Io. Io sono Quello”. Nel cogliere questo chiasma per dirla
con Merleau-Ponty (Il Visibile e l’Invisibile, Bompiani, 1969) –
l’osservatore esperisce la relazione del proprio corpo con il mondo, si
relaziona ad esso in una realtà fluttuante che mette in crisi l’evidenza
delle cose. La simultaneità dello spazio e del tempo, la loro coesione
tra corpo oggettivo e corpo fenomenologico, fanno si che visibile e
tangibile si riunifichino in un’identità consapevole. L’arte è cosa
mentale affermava Leonardo e mai come adesso che l’esautorazione dei
codici è giunta a compimento, il visibile sottende all’invisibile
trascendenza dell’idea che preesiste alla forma.
L’idea acquista autonomia dalle immagini che mette in atto proprio per
questa sua natura trascendente, rafforzando l’importanza del progetto e
della ricerca tesa sempre a minimizzare lo scarto tra idea e
realizzazione. Come lo scienziato l’artista nel realizzare l’opera,
assume le vesti del ricercatore ma non avanza pretese di sostituirsi
agli esperti delle discipline che di volta in volta egli indaga, anzi li
coinvolge, rendendoli parte integrante attraverso l’apporto delle loro
conoscenze specifiche. L’osmosi che si genera produce un reciproco
spostamento all’interno dei rispettivi campi d’indagine: l’artista si
avvicina alla scienza e lo scienziato si avvicina all’arte, come
espresso dal fisico Marco Ciotti (fisico ricercatore del Dipartimento
fusione ENEA Frascati, collaboratore tecnico al progetto Flottage,
1995). Spinto dall’artista lo scienziato si abbandona ad un viaggio
esplorativo nella propria sensibilità, un flusso cogitativo stimolato
dalla radiazione termica, uno “stream of consciousness” guidato dai
binari della logica, una scientificità astratta dal “caos programmato”.
Lo scienziato era abituato a stupirsi nel guardare il cielo stellato e
ad immaginare il pulsare dell’universo. Ora impara a sentire il pulsare
termico della materia, questo brulichio di fotoni assorbiti e riemessi,
aiutato dalla conoscenza delle leggi fisiche. Si guarda intorno e cerca
di tradurre le immagini che passano attraverso i suoi occhi in immagini
termiche, un continuo esercizio di traslazione di frequenza, dai corpi
che riflettono le sorgenti sparse per la stanza, non solo lampade ma
computer, cavi, termosifoni, esseri viventi, se stessi, fino ai propri
limiti. E’ qui che lo aiuta l’artista che con la sua concezione dinamica
dell’immagine, con la sua sensibilità interiore, traccia i primi
sentieri in questo mondo ove la forma si sfalda e alle idee si aggiunge
una dimensione.
Il dialogo che da sempre MUSIS ha cercato di attivare in una
interdisciplinarietà dei saperi ed in questo caso fra Arte e Scienza, ha
reso possibile attraverso l’interazione di soggetti diversi la
realizzazione dell’opera Flottage che altrimenti sarebbe risultata di
difficile concretizzazione per l’impiego dei mezzi impiegati.
Attraverso la collaborazione tra MUSIS e Monti si è inoltre
stigmatizzato con evidenza, un nuovo tipo di rapporto che oltre a veder
coincidere intenti comuni rivolti alla ricerca e soprattutto alla sua
divulgazione, fa rileggere possibili scenari futuri.
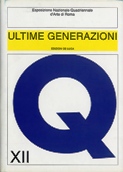 “Musis e Monti” “Musis e Monti”
di
Luigi Campanella,
in: IV Settimana della Cultura Scientifica Europea,
Roma, Musis 1996
Capitolo II
QUADRIENNALE DI ROMA
Settembre 1996
|

