
Paolo
Monti Bibliografia
Archivio ▪ 1992 |
- Invito Italiano -
ACQUE TECNOLOGICHE
Come talent scout ho cercato di privilegiare non tanto la data
anagrafica, ma senz’altro, per almeno due dei tre artisti che
presento, l’inedito dei lavori e soprattutto il carattere aspro e
forte di una situazione che curiosamente si delinea come una
tendenza compatta alla quale ancora non saprei dare né un nome né
un’etichetta.
Per spiegare il carattere e il timbro di tale situazione non riesco
a non partire da molto lontano, a ritroso nel tempo, riprendendo una
domanda che spesso, negli anni 60, si pose il russo Koyre, ovvero
come mai il “macchinismo” non è nato venti secoli prima in Grecia,
dove a sostenerlo ci sarebbero stati sia le nozioni che le
possibilità. A questa domanda lo stesso Koyre rispose affermando che
la Grecia non ha costruito una vera tecnologia perché essa non ha
elaborato la fisica. E ancora che la stessa era filosoficamente
incapace di elaborare la fisica in quanto questa scienza è lo studio
dei fenomeni grazie alle nozioni matematiche ad algebriche; essa
corrisponde quindi alla verifica di una struttura
matematico-geometrica presente in natura. Dire ciò equivaleva per i
greci all’affermare che non esisteva proprio quella dualità tra
sfera celeste e terrestre, tra ordine superiore e ordine inferiore,
dualità che sosteneva in gran parte l’impalcatura del pensiero
greco.
Nell’esempio più eclatante di una simile idiosincrasia, in Platone
che fa della matematica la scienza per eccellenza, gli oggetti della
geometria possiedono una realtà più alta di quella del mondo
naturale, più consona alla natura celeste dell’intelletto.
Nell’universo plutoniano l’intelletto nulla ha a che fare con le
cose del mondo sensibile, con la materia, se non attraverso la
mediazione della ragione. Anche Aristotele si schierò a favore di
questo dualismo, non riconoscendo esistenza di ordine e di ciclicità
nella realtà. Tale scissione causò quindi solo lo sviluppo delle
scienze astronomiche concependo la possibilità che i movimenti delle
sfere e degli astri fossero conformi alle leggi della geometria,
indicando quella “perfezione celeste” che passò poi in eredità al
medioevo occidentale.
Come disse Lucien Febvre l’uomo medievale, come quello antico,
poteva eseguire forse dei calcoli astronomici ma non sapeva
calcolare nell’esperienza comune, era privo del linguaggio numerale
e aritmetico.
L’uso delle cifre Gobar, o cosiddette cifre arabe, si diffuse
infatti esclusivamente nei calendari per ecclesiastici, negli
almanacchi per astrologi e medici, o tra i grossi mercanti; il mondo
comune utilizzava ancora le minuscole romane, con le quali era
impossibile fare qualsiasi operazione scritta, visto che un’unità
decimale può arrivare a coprire anche quattro colonne, come nel caso
del numero VIII.
Così nella scienza la tecnologia e la fisica appaiono nel momento
stesso in cui la teoria si converte in azione è l’intelligenza
teorica alla realtà. Il punto di congiunzione parte forse proprio da
Galileo e continua in un’ottica ancora umanistica fino a Descartes,
che concepisce il progresso come ciò che rende l’uomo “maestro e
possessore della natura”.
Nell’arte è chiaro che tutto ciò diviene molto relativo, ma è
significativo che l’intento primario sia stato comunque sempre
quello di una tensione o un incontro, se non tra sfera celeste e
sfera terrestre, dell’identità soggettiva dell’uomo come artefice
con la perfezione e l’ignoto di Dio nel fare stesso dell’azione
creatrice.
E se il manierismo ha potuto incarnare il massimo momento di
dissolvenza di questa tensione, in misura spaziale attraverso il
decentramento prospettico, in misura temporale attraverso
l’assemblaggio di momenti diversi come punti di vista differenti;
pure con lo strumento allegorico componeva una definizione in res
del presente. Al punto che il passaggio al barocco non ha
rappresentato delle scosse visive così radicali, almeno a mio
parere, o per lo meno, proprio questo attimo presente, derivato in
qualche modo dal manierismo, ha potuto ricucire la divaricazione,
questa deriva dei continenti, nel concetto stesso dell’immanenza
come dimostrazione dell’esistere.
Ma al di là dello sforzo di illustrare l’esistenza di Dio del
barocco, ciò che risulterà significativo sarà la discesa della
teoria nella prassi? Sarà come il clic di un formidabile meccanismo
che grazie ad un contatto di natura elettrica si mette in moto? Al
presente, il tempo del manierismo, il barocco aggiunge lo spazio
della alta ed ecco che automaticamente il progetto scientifico
moderno si mette in moto.
Questa possibilità, questo incontro tra spazio e tempo nel presente
della visione ha senz’altro avuto una ragione e un avvio
tecnologico, o meglio la teoria scesa nella prassi, come ricorda
Koyre, ha costruito lo strumento. Allora si può pensare al
telescopio di Galileo. Quest’ultimo servendosi della scoperta del
cannocchiale, da parte degli olandesi, ha elaborato la teoria
necessaria alla costruzione dei suoi perspicilli dilata lo spazio
della visione nella dimensione extraterrestre dell’universo.
Come definire i soffitti barocchi se non il prodotto di uno
strumento tecnologico, o il prodotto di una teoria, di una
possibilità che sta a monte come ad esempio l’ideazione del
telescopio?
Questa nozione di strumento, di tecnologia al servizio della
visione, della misura calata nel mondo della realtà, è non solo
dimostrata scientificamente ma sperimentata nel suo valore
d’immagine a sé, è quanto in definitiva perseguono i tre artisti
Karpuseeler, Lombardi e Monti. E le loro problematiche hanno dei
natali lontani, coinvolgono le peripezie del pensiero umano, il
perenne incontro-scontro con la realtà e con l’idea e il sogno,
sempre ammettendo che tra le tre entità possa esserci
un’improbabilissima scissione.
Il progresso scientifico ci ha portati verso la misura della realtà.
L’impressione che danno questi tre artisti è che vogliono misurare
il sogno. Siamo in sentore di eresia? I più arricciano il naso
affermando che in fin dei conti ciò che il pensiero greco voleva
proteggere era un’identità superiore? Oppure si vuole dare uno
statuto di realtà all’arte, di veridicità?
Vorrei fugare ogni dubbio. Nel decennio ’90 l’arte ormai e a
dispetto di chi non ci crede, di chi vuol far finta che non esiste
perché non convinto della veridicità del suo statuto. L’arte non è
una parola che significa buone intenzioni, moralità e chissà quale
altro conCetto disinteresto e plo poetico, o tale da ricordare la
Controriforma e appunto il barocco nel suo basarsi su una verità
illusoria. E proprio le macchine visive barocche denunciarono, nei
secoli successivi, la forza di coercizione e di dimostrazione
propagandistica delle committenze. Questi dipinti rappresentarono
così un incancellabile dato di fatto.
Dunque l’arte è e fa la storia a dispetto di chi non la considera.
Come la realtà. la natura, la terra sono e hanno scritto la storia
milioni di anni prima della nascita del pensiero scientifico.
La strada di questi tre artisti coincide con una vita di conoscenza
e come tale è possibile e auspicabile, una scommessa con il futuro,
una tra le tante reti gettate dal pensiero umano.
E’ curioso pensare che proprio il progresso scientifico, la pratica
della misura e della quantizzazione hanno condotto ad un concetto di
relatività della realtà. Cosa e dove potrà condurre una via che
persegue un concetto di misurazione e di tecnicismo applicato
all’arte e alla sfera delle idee e del sogno? E’ interessante porsi
la domanda.
L’importante è che attraverso questa strada non si battano,
nell’inconsapevolezza del dejavu, dei percorsi già fatti. Rischio
possibile per chi si propone delle mete dimostrative, tali da poter
ricondurre proprio ad una concezione barocca.
Dalle iniziali ricerche di questi artisti quello che si può
osservare è una certa ambiguità – vicina alla scissione – tra lo
strumento artistico e il risultato formale. Dove la macchina, o lo
strumento che provoca un certo fenomeno, rimanda comunque a
qualcos’altro, ad un circuito tra mente e dato.
Questi risultati ricordano molto, nella loro forza sperimentale, le
macchine elettriche dell’artista giapponese Atsuko Tanaka, tanto per
trovare dei riferimenti. Ma soprattutto occorre pensare all’italiano
Maurizio Mochetti. Artisti questi che hanno sperimentato sul filo di
confine tra arte e scienza-tecnologica senza porsi dei fini
dimostrativi.
Mi sembra quindi importante, a proposito della continua esigenza di
gettare reti in acque inusuali, che vi siano dei soggetti che
contribuiscono in qualche modo ad una “pesca collettiva” e
trasformino questo in una scommessa, in una apprensiva palpitazione
sul futuro.
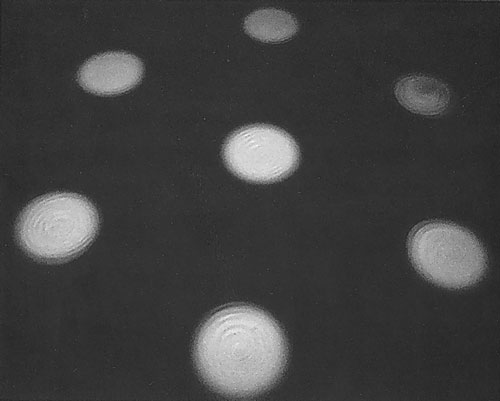
Paolo Monti, Onde elastiche
Ada Lombardi
Nata a Roma ove risiede. Laureata in Lettere Moderne
all’Università “La Sapienza” di Roma, è assistente alla Cattedra di
Storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari.
Ha curato e partecipato alla realizzazione di diverse mostre tra
cui: Eroi-Antieroi, Galleria Creonidos in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Atene 1991 (cura); Progetti e
oggetti, Galleria Bianca Pilat, Milano 1991 (cura); Arie Fonti del
Clitunno, Festival dei Due Mondi di Spoleto 1991 (assistente alla
cura); De Europa Associazione Culturale “La Salerniana”,
Erice/Assessorato alla Cultura, Comune di Atene 1991
(coordinamento). Collabora con le riviste d’arte: Opening, New Art
International, Lapiz, Flash Art, Segno. Suoi articoli sono stati
pubblicati su Frigidaire, Il Lunedì di Repubblica e Mondo Operaio.
Ha scritto numerosi saggi.

“Invito Italiano”
di Ada Lombardi
in: Ter, Vol.III, a cura di Achille
Bonito Oliva,
Pescara, Umberto Sala Editore 1992,
pp. 11,
40,41,42,43,44,101,119
|
|
 |

